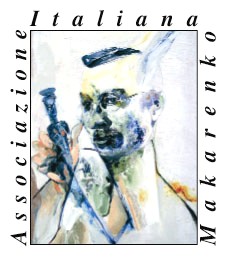di Alfonso Pascale
Con gelida e noiosa oratoria, vagamente andreottiana, Giuseppe Conte ha sciorinato, a Montecitorio, novanta minuti di cose da fare, abbastanza contraddittorie tra loro. È da populisti di sinistra estendere diritti ai cittadini senza dar luogo a doveri, specificamente fiscali oppure di riduzioni di altre voci di spesa. Il mancato riconoscimento di questi altri doveri (che sono poi l’altra metà del bilancio pubblico) rischia di trasformare in regali temporanei la concessione di diritti giustamente descritti come conquiste di civiltà o applicazioni della nostra costituzione. A parte la giusta ed efficace rimessa dell’Italia in linea con le sue scelte strategiche fondamentali (Unione Europea, Nato, alleanza con gli USA e impegno nel Mediterraneo allargato), il resto del discorso del presidente del Consiglio è stato molto generico: un catalogo di ovvietà, scelte nascoste da parole suscettibili di interpretazioni incerte. Ma comunque è servito ad ottenere la fiducia sia alla Camera che al Senato. Ed era questo che sostanzialmente M5S, PD e Leu si aspettavano. Ma con quali benefici? con quali costi? e a danno di chi?
Le origini della crisi politica
Per comprendere l’esito della crisi politica che si è consumata durante il mese di agosto e che ha dato vita al governo Conte bis, bisogna innanzitutto esaminare i motivi del crollo del governo giallo-verde.
Il primo governo Conte è caduto per ragioni di programma e di tattica politica. Vediamo le prime. È scivolato sulle infrastrutture, un tema che attiene allo sviluppo economico di tutto il Paese, ma in primo luogo allo sviluppo del Nord. È inciampato sull’autonomia regionale: l’autonomia rivendicata dalle Regioni del Nord. I due elettorati, quello leghista, presente principalmente al Nord, e quello pentastellato, insediato soprattutto al Sud, hanno esercitato ognuno una pressione opposta sulle proprie rappresentanze politiche. Anche quella parte di elettorato leghista meridionale si è fatta sentire per costringere il leader a fermarsi. Le contraddizioni programmatiche del “contratto” sono tutte drammaticamente venute al pettine. E non c’era più la possibilità di fare un solo passo avanti.
Passiamo ora alle ragioni di tattica politica che si sono rivelate determinanti. Alle elezioni europee Salvini è passato dal 17% delle elezioni nazionali al 34%, ma i sondaggi più recenti lo davano al 38%. I Cinque Stelle hanno fatto il percorso inverso, passando dal 32,7% delle elezioni nazionali al 17,07% delle europee. La prospettiva politica per Salvini è diventata irresistibile: consolidare sul piano nazionale il voto europeo. Un obiettivo da conseguire sradicando l’Italia dall’Europa per sospingerla nei campi di battaglia mondiali, dove si combattono – per ora solo a freddo – la Cina, gli USA, la Russia, l’India. La tattica che il capo della Lega aveva ideato era quella di stare nell’arena globale alleandosi ora con un leader, ora con l’altro. Sul piano degli assetti della nostra democrazia, Salvini non aveva mai pensato di ricostruire i Fasci di combattimento del 1919, ma era attratto dallo stile di Putin e Orbán che coltivano apertamente l’idea di demolire la democrazia liberale.
L’azzardo rovinoso di Salvini
Dinanzi a questa situazione pericolosa per il Paese, il PD e Forza Italia da un anno protestavano in modo del tutto inefficace a causa delle proprie divisioni interne. Un vociare inconsulto, cacofonico, fastidioso. L’impressione generale era quella di una assenza completa dell’opposizione.
Nel M5S l’aria era pesante. I grillini non consideravano la volontà di Salvini di correre al voto un pericolo per il Paese. Anzi, erano stati proprio loro a promettere un referendum per uscire dall’Euro. E dunque non vedevano i propositi geopolitici del capo leghista con preoccupazione. I pentastellati avevano appena approvato insieme al loro partner la riduzione dei parlamentari e sostenuto il decreto sicurezza. E dunque non percepivano i rischi per la democrazia liberale che il disegno salviniano conteneva. Essi guardavano con allarme la corsa al voto esclusivamente per ragioni esistenziali: le elezioni subito minacciavano semplicemente la sopravvivenza dei Cinque Stelle. Ma non lo potevano confessare. E dunque non battevano ciglio. A quel punto Salvini ha pensato di fare il colpo. Ma è inciampato clamorosamente nella propria tracotanza orgogliosa ed è caduto. Di Maio lo ha seguito e, travolto dall’hybris salviniano, ha distrutto in parte la sua immagine. E ad approfittare subito della situazione è stato Conte, che si è affrancato dai due, trovando una sponda in Casaleggio e Grillo.
Il matrimonio di convenienza PD-M5S
Dinanzi alla caduta di Salvini e Di Maio, Berlusconi si è rivolto al capo della Lega per invitarlo ad andare uniti alle elezioni per vincerle. Un obiettivo realistico viste le condizioni pietose della sinistra. E Zingaretti, anche lui, ha pensato al voto subito, certo di perdere, ma con l’intento di prendere finalmente il controllo dei gruppi parlamentari. A quel punto gli unici a veder chiara dinanzi a sé la prospettiva di una drastica riduzione della propria presenza parlamentare erano Renzi e il M5S. Per scongiurare quello scenario, l’ex presidente del consiglio ha prontamente accantonato ogni remora ad allearsi con Grillo e ha immediatamente trovato nel PD alleati già pronti, in nome di forti propensioni governiste e filogrilline.
È vero che nell’elettorato del M5S si era trasferita una buona parte dell’elettorato di sinistra. Ma aveva giocato nel trasferimento l’eredità della parte peggiore della sinistra; l’eredità che ha albergato nel cuore di una storia complessa, ricca, varia, che però aveva, in un suo sentimento profondo e difficilmente governato dai riformisti, il pauperismo, il disprezzo per la “casta”, un’ostilità storicamente consolidata per l’Europa, per la globalizzazione e indifferenziatamente per il capitale. Si sarebbe dovuto riflettere di più su questo punto. Nel programma populista di Conte è chiaramente riflessa quella eredità. E compito dei riformisti sarebbe dovuto essere quello di continuare a combattere questa eredità, non incoraggiarla come fanno i ben noti burocrati della politica in attesa di onorificenze. Si sarebbe dovuto andare ad una grande battaglia culturale, prima ancora che politica contro il vecchiume che continua ad albergare anche nel PD. E invece a tutto questo si è rinunciato.
Quale prospettiva ha indicato questo governo? L’unico traguardo chiaro è il ritorno alle antiche alleanze internazionali. E la designazione di Gentiloni a commissario agli Affari economici dell’UE da parte di Ursula Von der Leyne è sicuramente un positivo riscontro di questo cambio di marcia. Per il resto dobbiamo rimetterci alle prospettive indicate da ciascuno dei partner. Il PD si propone di fermare Salvini e di ridurlo elettoralmente. Il primo obiettivo è stato facilmente raggiunto, complice Salvini. Quanto al secondo, si vedrà. IL M5S continua di fatto a perseguire il programma di governo già concordato con la Lega, cambiando tuttavia spalla al fucile. Resta imprevedibile in quel partito la competizione per la leadership e non si sa nulla se c’è la volontà in qualcuno dei protagonisti di definire un asse politico-culturale ben identificabile.
L’eclisse del riformismo
Chi pagherà il prezzo più alto di questa operazione sarà il PD che ha dovuto, per prima cosa, ingoiare la scelta grillina – fatta propria dalla Lega – di tagliare drasticamente i parlamentari. E per giustificare la conversione ha proposto ulteriori modifiche della Carta costituzionale. L’ipotesi iniziale consisteva nel riscrivere l’intero progetto e inserire il cavallo di battaglia pentastellato in un contesto complessivo. Ma non c’è stato niente da fare. L’unica soluzione possibile è quella di approvare il taglio ma con una serie di contestuali garanzie. L’idea che circola informalmente è di presentare alla Camera e al Senato due altri provvedimenti di iniziativa parlamentare.
Il primo è costituzionale e prevede l’introduzione della sfiducia costruttiva (si può presentare una mozione di sfiducia solo indicando una maggioranza alternativa, un fattore di stabilità), la riduzione del numero dei delegati regionali che partecipano all’elezione del presidente della Repubblica, la partecipazione dei governatori all’Assemblea di Palazzo Madama quando vengono discusse e scrutinate norme riguardanti le Regioni, la parificazione di elettorato attivo e passivo tra i due rami del Parlamento (18 anni per votare, 25 per essere eletti) e il voto di fiducia all’esecutivo in seduta congiunta per limitare i pericoli – spesso registrati negli ultimi anni – derivanti dalla presenza di numeri diversi a Montecitorio e Palazzo Madama. L’accordo demo-grillino, però, non si poggerebbe solo sui contenuti. Il PD ha chiesto e ottenuto di far entrare in vigore tutte queste modifiche contestualmente al taglio dei parlamentari. Una legge del 1970 permetterebbe, infatti, di organizzare una sorta di “referendum day”. Un solo giorno da dedicare ai referendum confermativi per dare il via libera alle due leggi costituzionali.
Parallelamente dovrebbe procedere il secondo provvedimento concordato dai capigruppo dei due partiti. Non si tratta di una proposta di legge costituzionale, ma ordinaria. Riguarda la riforma elettorale. Le “garanzie” invocate dal PD, infatti, sono centrate proprio sul sistema di voto. Quello in vigore (un misto tra proporzionale e maggioritario), per molti presenta dei profili di incostituzionalità. In particolare se davvero verrà ridotto il numero di deputati e soprattutto di senatori. In alcune regioni, ad esempio, potrebbe non essere garantito il principio di rappresentanza. Nelle circoscrizioni meno popolose persino un partito del 15 per cento non eleggerebbe nemmeno un rappresentante. L’intesa di massima già raggiunta, allora, farebbe perno su un sostanziale ritorno alla legge proporzionale tout court. Come nella Prima Repubblica. Temperata solo da una soglia di sbarramento al 4 per cento.
Con questo accordo il PD sancisce l’abbandono definitivo del “partito a vocazione maggioritaria”, la rinuncia ad ogni bipolarismo e, pertanto, ad ogni vera riforma istituzionale, quella che prevede la possibilità per i cittadini di scegliere, almeno indirettamente, il governo e di garantirne la stabilità. Il PD dunque torna indietro verso il Paese di sempre: il Paese dell’indecisionismo, del galleggiamento, del debito pubblico, delle riforme impossibili. Un Paese stanco, senza audacia. Un Paese democristiano-doroteo.
Si potrebbe anche accettare questo ritorno al passato, in nome del realismo politico, ma resta il dubbio se un governo siffatto davvero sarà in grado di ridimensionare il blocco elettorale che sostiene la Lega di Salvini. Un blocco sociale e produttivo che si aspetta, invece, riforme della giustizia e dell’amministrazione, decisioni rapide, governi stabili, politiche per la crescita e lo sviluppo.
Ci sarà almeno in Europa uno scatto riformista?
E infine anche la chiara scelta europeista del governo Conte bis rischia di essere insufficiente se non sarà accompagnata da una coraggiosa volontà di riforma delle famiglie politiche che hanno votato la presidente della Commissione europea.
La governance dell’Unione Europea – ha scritto Sergio Fabbrini – produce effetti asimmetrici tra Paesi del nord e del sud e soprattutto è divenuta (per via della sfiducia prodotta dalla crisi dell’euro) un sistema di crescente centralizzazione regolativa delle politiche economiche nazionali. È qui che bisognerà intervenire. L’Eurozona, in particolare, dovrà avviare una riforma per superare il modello univoco di convergenza che si è imposto nel corso della crisi dell’euro. Modello coerente con le strutture di alcuni Paesi ma non di altri.
Anziché approfondire questa riforma e agevolare i cittadini nel comprendere il significato politico di un governo che dice di voler essere più europeo, i media si soffermano solo sulla rivendicazione di una maggiore flessibilità nell’interpretazione del Patto di stabilità e crescita. Le due cose sono del tutto indipendenti l’una dall’altra. Confonderle, significa confondere le idee dei cittadini.
La riforma della governance è una proposta che ha avanzato Macron. Il quale è oggi del tutto isolato perché Merkel nicchia. L’Italia si appresta a diventare lo stretto alleato di Macron per portare in porto questa riforma. E’ questo il senso del gioco di squadra che dovranno fare Conte, Gualtieri, Sassoli, Tajani e Gentiloni, d’intesa con Macron, per smuovere la Germania.
La maggiore flessibilità nell’interpretare il Patto di stabilità è un intervento che serve, invece, all’Italia nell’immediato. Però, questa richiesta sarà tanto più credibile quanto più sarà accompagnata da scelte coerenti al nostro interno, capaci di favorire insieme crescita economica e sostenibilità del debito pubblico. E questa cosa non c’entra nulla con la riforma della governance dell’UE.
Tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del nuovo millennio, in Italia fiorirono numerosi studi e ricerche sulla Costituzione Europea. “Il Mulino” ne fece addirittura una collana. Università e fondazioni lavorarono alacremente su questo tema. Cosa impedisce al presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, e al presidente della Commissione per gli Affari costituzionali, Tajani, di promuovere un nuovo ciclo di studi e ricerche sul rilancio dell’integrazione europea? Cosa impedisce a Zingaretti di creare una “piattaforma Voltaire” (alternativa a quella “Rousseau”) per diffondere una nuova narrazione sull’Europa e sulla democrazia europea?